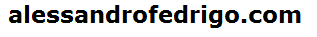
|
Ad un certo punto del mio percorso musicale iniziai ad essere ossessionato da una domanda: è possibile trovare un modo per improvvisare che non sia quello convenzionale degli accordi/scale/tonalità/modi ma che non sia nemmeno quello dell’improvvisazione libera? La domanda poi inizio a perfezionarsi: è possibile improvvisare/comporre utilizzando un linguaggio che organizzi i suoni in modo non convenzionale (non idiomatico) ma che abbia una precisa “regolazione” dei rapporti tra loro? Avevo notizia che alcuni jazzisti sperimentassero in modo “non convenzionali”, Steve Coleman e Henry Threadgill per esempio e poi conoscevo superficialmente il lavoro di molti compositori della musica contemporanea del novecento e di alcuni teorici della musica in questo campo. Decisi dunque di iniziare una ricerca personale per sperimentare alcune possibilità di organizzazione delle altezze per comporre/improvvisare. La prima composizione che scrissi seguendo questa idea fu “Saturno” nella versione cantata "Child of the Rings" (score, music) che nasce da una sequenza “a spirale” attorno alla nota B, la sequenza della linea di basso è infatti Bb C A C# Ab D G Eb F# E, il pezzo poneva una serie di problemi: un improvvisatore come poteva relazionarsi a questo materiale? Come si poteva esplorare lo spazio sonoro che questa sequenza di suoni intercettava in modo “organico”? Sempre nello stesso periodo scrissi un’altra composizione intitolata “Protone” (score, music) basata su una sequenza di intervalli che diventano sempre più ampi: la sequenza iniziale è infatti C Db (2m), E D (2M), Eb Gb (3m), F A (3M), B F# (p4), G Db (b5), Ab Eb (p5), C# F (a5), F A (6M), Eb Db, C Db (7M) E E (8). Questa sequenza poneva due problemi, il primo: gli intervalli erano ordinati per ampiezza ma tra le coppie di intervalli si trovavano degli altri intervalli disposti casualmente. Il secondo: un improvvisatore come poteva relazionarsi a questo materiale? L’idea degli intervalli mi sembrò interessante e iniziai ad esplorarla più intensamente, nella composizione “B1” (score, music) per esempio l’improvvisazione si svolge su una sorta di giro armonico così organizzato: quattro battute con l’intervallo di seconda minore, quattro con la terza minore, quattro con la sesta maggiore e quattro con la quinta diminuita. Chiamai questo uso degli intervalli “prevalente” nel senso che l’improvvisatore era invitato ad utilizzare questi intervalli per coppie di note senza necessariamente preoccuparsi che fossero presenti in tutta la sequenza di note che avrebbe suonato. Altra tecnica compositiva che mi sembrava interessante è quella della composizione con dodici note diverse, attraverso le serie dodecafonica iniziai ad esplorare l’inversione, la retrogradazione e nacquero un alcune composizioni come “Prima Serie” (score) per quartetto e “Marte 4” (score, music) per basso solo. La domanda a cui non riuscivo a rispondere in questo caso era: come poteva un improvvisatore relazionarsi alla serie in tempo reale? Come poteva trattarla estemporaneamente? Un’altra idea che cominciò ad affacciarsi fu questa: se utilizzo una coppia di intervalli (ad esempio (m2/M3) posso comporre delle melodie che utilizzino esclusivamente questi intervalli e posso dare all’improvvisatore una “regola” sufficientemente flessibile e organica per costruire delle melodie estemporanee. Nacque così una composizione dal titolo “Origami”(score) e questa idea mi sembrò da subito promettente. La mia esplorazione andò avanti in modo disordinato tra varie tecniche: alcune composizioni dedicate all’uso degli intervalli “Space Jazz Astro Bop” (score, music) e “Jon Futuru” (score, music), altre dove si sperimentavano le coppie di intervalli “Hagelin” (score, music),“Il Cerchio”(score, music), “Hans” (score, music), altre ancora dove ho utilizzato scale “sintetiche” per esempio “Spirali” (score, music) e “Obscurio” (score, music), oppure dove applicavo queste tecniche mescolandole “Due Lune” (score, music). Con la nascita di XYQuartet potei approfondire le mie idee e provare a dare risposte a questi quesiti anche grazie alla collaborazione continua con altri musicisti (Nicola Fazzini in primis e Saverio Tasca e Luca Colussi). In questa formazione divenne da subito importante l’esplorazione della “forma” cioè dell’evoluzione della composizione e dei materiali che la generano, la musica divenne molto più organica e organizzata. Un altro argomento che trovai particolarmente interessante da esplorare fu quello dei “pitch class set” che mi fu suggerito da Nicola Fazzini in particolare organizzati per esacordi, fu così che nacquero alcune composizioni come “Mono Esa Tono” (score, music), e “ Gagarin” (score, music) piuttosto che “Nautilus” (score, music) per solo basso. A questo punto scrissi una composizione dal titolo “Rakesh” (score, music), basata su una serie dodecafonica composta da due intervalli e dedicata a Rakesh Sharma il primo astronauta indiano, e contenuta nel cd “Orbite” di XYQuartet. Gli intervalli sono la terza maggiore (M3 o 4) e la quarta giusta (p4 o 5). Il pezzo aveva un suono che mi sentii di definire “antigravitazionale”, non c’era un centro tonale stabilito e in questo senso in questo senso dava la suggestione di un astronauta nella sua navicella. Questa composizione fu molto importante per me, perché capii che per degli improvvisatori il materiale dato, ovvero i due intervalli, era relativamente flessibile da utilizzare e poteva essere esplorato a fondo, il seguito della mia ricerca sarà proprio orientato a fornire a degli improvvisatori (o a compositori) delle pratiche concrete per l’esplorazione di questo materiale. Ho pensato di raccogliere le composizioni che ho qui citato in una playlist, vi auguro buon ascolto. |
| BIO | PROGETTI | AUDIO | VIDEO | DISCOGRAFIA | CONCERTI | FOTO | RICERCHE | CONTATTI | LINK |